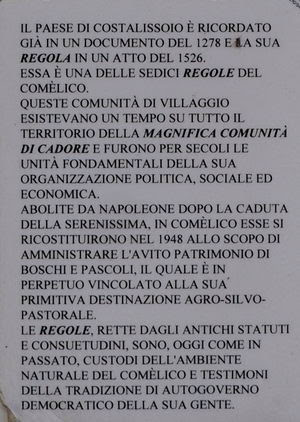Venezia è città d’arte per antonomasia, la capitale del romanticismo, meta da sogno sospesa nel tempo tra la terra e l’acqua eppure potrebbe essere descritta attraverso i numeti. Infatti, Venezia, che prima di tutto è un topos geografico reale, “ha molti numeri” importanti i quali, oltre che per individuarla e descriverla, risultano preziosi per comprenderne più a fondo la natura. Ecco così che, anche attraverso una semplice enumerazione di dati, inesorabile emerge l’immagine di una città ancora una volta differente dalle altre, da un lato sempre sorprendente e magica, dall’altro pur con la sua fragilità e complessità
Venezia è composta da 6 sestieri: San Marco con 5.562 numeri civici; Dorso Duro con 3004 numeri civici; Cannaregio con 6.423 numeri civici; Santa Croce con 2.344 numeri civici; San Polo con 3.144 numeri civici; Castello con 6.827 numeri civici.
Un’unica piazza che è la meraviglia di Piazza San Marco e un unico palazzo, Palazzo Ducale.
118 sono le isole che la compongono
420 sono i ponti che attraversano i canali
4 sono i ponti sul Canal Grande: Il Ponte della Costituzione più noto come Calatrava, dal suo progettista, il Ponte degli Scalzi o della stazione, il Ponte di Rialto e il Ponte dell’Accademia. I piccoli ponti sono 300 in pietra 59 in ferro 49 in legno più il Ponte dei tre ponti.
Un solo ponte di accesso alla città il ponte della Libertà un tempo noto come Ponte di Littorio, costruito nel periodo fascista affiancato anni dopo dal ponte della Ferrovia.
177 sono i rii che si intersecano
3 soli canali : Il Canal Grande, il Canale della Giudecca e Il Canale di Cannaregio.
135 sono i campi
196 i campielli
380 le corti
7 i campazzi
1198 calli
367 rami
52 rio terrà
42 salizade
10 rughe
1 strada ( Nova)
2 vie
142 fontane
256 pozzi pubblici
circa 2.500 pozzi privati.
La sua superfice è di 415,9 chilometri quadrati e conta 250191 al 31 maggio 2024.
Le Chiese sono 98 quelle di culto, 26 quelle sconsacrate 2 di altri culti, gli armeni e i greco-ortodossi e ben 40 quelle che sono state demolite. 117 sono i campanili.
Sono questi numeri importanti da ricordare in quanto Venezia non è solo San Marco e Rialto ma l’insieme di tante calli, campi, campielli, rii, ponti che sono i testimoni tangibili di una storia che millenaria che rimane nel cuore non solo dei veneziani ma di tutti quelli che la visitano e la amano.
Alberta Bellussi
- 27 September 2024
- No Comments