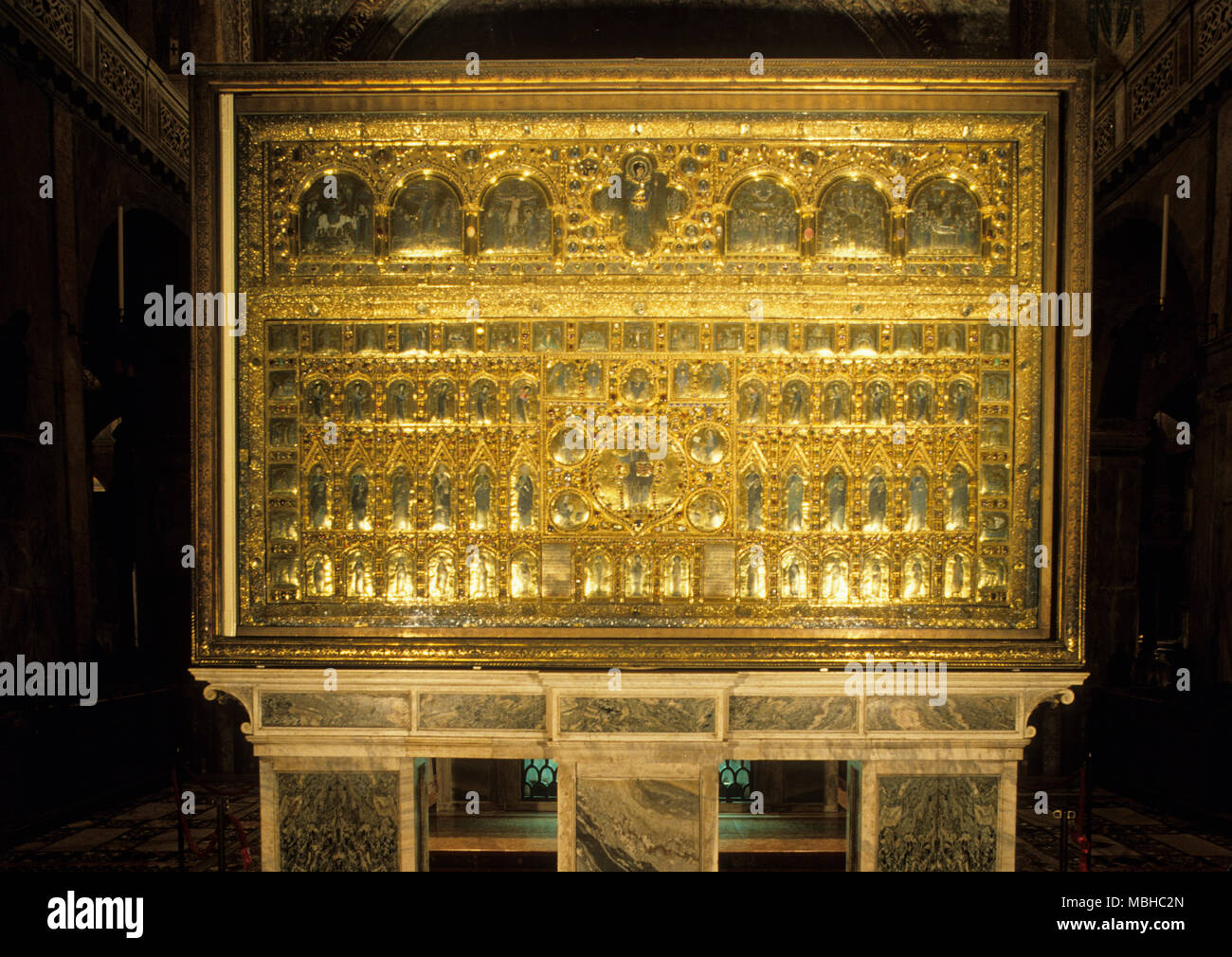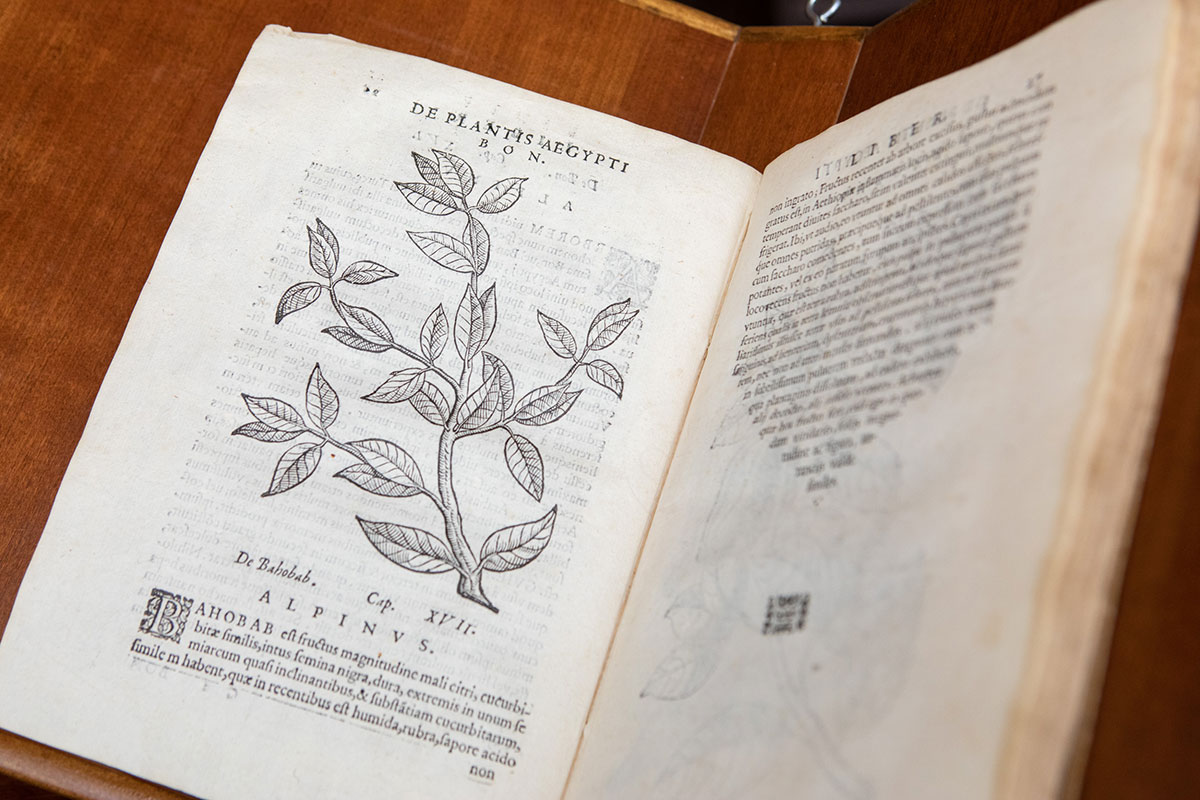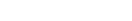Lo “Schieson Trevisan” è, sicuramente, un tassello importante della nostra tradizione perché era presente in tutte le case della campagna trevigiana e rappresentava lo strumento per conoscere il momento giusto per approntare le semine, per fare il buon vino, gli innesti delle piante, e le raccolte, insomma tutte quelle attività utili per programmare l’annata agricola, non per ultimo, la cura della propria persona con decotti ed erbe particolare, anche queste da raccogliere e lavorare in un particolare momento della fase lunare; ma anche fiere, mercati, appuntamenti vari della Marca Trevigiana.
Lo Schieson scandiva, con le lune, i proverbi, i consigli, gli appuntamenti, la vita della società contadina già dal ‘700. Un lunario che ha 307 anni, è nato nel 1716 ed è l’almanacco più antico d’Italia e d’Europa.
E’ sempre stato consultato per i suoi “pronosteghi” che raramente ha sbagliato anche alcuni che al leggerli potevano sembrare delle farneticazioni; infatti ha annunciato, nel 1797, la fine della Serenissima e nel 1989 la caduta del muro di Berlino.
Il nome di questo calendario deriva da quello dialettale di un albero, “s-cieson”, detto anche “pisolera, s-cesson, bessoler”, in italiano bagarolo o schiacciasassi ed è stato l’ispiratore della prima copia, “Schieson de Casacorba” , dove nasce il Sile, scritto già dal 1716-17 da un prete, si ispirava a questa grande pianta ombrosa che si alzava davanti la chiesa del paese e sotto alla quale la gente si fermava a chiacchierare e discutere.
Il calendario funzionava come una specie di amplificatore delle chiacchiere e delle critiche della gente comune e, siccome i rami flessibili del bagolaro servivano a far fruste, si proponeva anche di bacchettare o fustigare i vizi più comuni.
Dal 1744 il calendario cambiò nome in “Schieson Trevisan” e fu edito da Giovanni Pozzobon, poeta trevigiano che, da garzone di stamperia si dedicò, in età adulta, alla poesia scrivendo versi nel nativo dialetto e componendo almanacchi, che pubblicò per 42 anni dal 1744 al 1786. Tra questi il “Pronostego“, pronostico o poesia sull’anno, ricca di ironia e battute di spirito.
Come scrisse Bartolomeo Gamba, il “popolare libretto” era pieno di “buoni morali insegnamenti, giammai contraddetti da verun espressione sfuggitagli in offesa della Religione o della decenza“. Fortunatissimo divenne il lunario del Pozzobon, tanto che venne tradotto anche in spagnolo, francese e tedesco e stampato in circa 40.000 copie; e quando l’edizione fu meglio ordinata e garantita da un privilegio concesso dal Veneto magistrato dei Riformatori, lo spaccio arrivò fino alle 80.000 copie. Pozzobon modificò la pubblicazione; il suo non fu solo un semplice calendario-lunario in folio da appendere limitato alle notizie metereologiche, lo rese più piacevole con le previsioni sull’anno che divenne, anche, la parte più ghiotta per l’ironia e le battute di spirito.
Nelle campagne di Godega di S. Urbano veniva venduto o regalato ad ambulanti che vendevano filati, aghi, casa per casa con il nome di lunario di “Bepo Gobo da Casier” perché questo è il nome del mago raffigurato poco sotto il nome dell’almanacco nonché autore nominale del Pronostego.
Succedeva che nel giorno della fiera agricola che ricorreva ogni anno la prima domenica di marzo e durava tre giorni, veniva spesso regalato a chi comprava piante o sementi. Il lunario comperato veniva esposto in cucina e quello regalato veniva appeso sulla porta della stalla insieme all’icona di S. Antonio Abate (festività del 17 gennaio), noto con il nome di “Santantoni del porzel“.
Era infatti quello il giorno in cui si macellava un maiale nutrito dalla generosità di tutto il paese, perché veniva comperato dal parroco il giorno di S. Pietro e Paolo (29 giugno) e poi lasciato libero di vagare di casa in casa. Dopo essere stato nutrito dalle famiglie e dalle borgate veniva macellato il 17 gennaio, e la “porzelaria” veniva distribuita ai poveri del paese.
La Fiera di Godega di S.Urbano e tutt’ora la prima fiera importante del bestiame, di piante e sementi dopo l’inverno. C’era allora un proverbio che così recitava: “Chi vol a morosa d’istà ghe compra i fighi al primo marcà ”.. questo perché le bancarelle dei dolciumi vendevano delle corone di fichi secchi, tenuti insieme da uno spago e chiamate in dialetto “morona de fighi” che lo spasimante regalava alla sua bella come segno di preferenza.
Vari editori si succedettero nella stampa del “Schieson Trevisan”, ed il passare degli anni non solo non l’ha scalfito, ma lo ha reso un simbolo importante della cultura, del mondo agricolo e dell’identità locale. Ora questa importante eredità è nelle mani dell’Associazione Trevisani nel mondo anche perché era il calendario dei nostri avi; quindi rappresenta, ancora oggi, un modo per non dimenticare le origini e sentirsi a casa, anche oltreoceano, conservando gelosamente la propria cultura fatta di storia, usanze, tradizioni locali. Lo Schieson Trevisan rappresenta anche un modo per non dimenticare le nostre origini e quelle dei nostri emigrati che per sentirsi a casa anche Oltreoceano, conservano gelosamente la propria cultura fatta di storia, usanze, tradizioni locali; è infatti ricercatissimo tra gli immigrati veneti che vivono per il mondo, oltre che nella Marca Trevigiana, che è persino andato sullo spazio, caricato nello Space Shuttle, assieme ai semi del radicchio, durante la missione STS-95 del 1998, nell’ambito del progetto Sem della Nasa, mirato alla sperimentazione degli effetti della microgravità sui semi e sulle piante.
Lo Schieson Trevisan rappresenta un ponte importante tra passato, presente e futuro, in un foglio dal sapore antico da appendere in un luogo facile da consultare, contiene un concentrato di Veneto: tradizioni, consigli, previsioni, proverbi simpatici tutto in dialetto e spesso con una rima ironica e simpatica, continuare a tener viva questa tradizione di “Bepo Gobo” e il suo lunario, giorno dopo giorno; sarebbe bello farlo conoscere e veicolare il suo valore iconico e simbolico anche i giovani di oggi perché siano anch’essi dei custodi gelosi delle radici del nostro albero e che a loro volta lo continuino a tramandare di generazione in generazione come accade dal 1717.
Alberta Bellussi