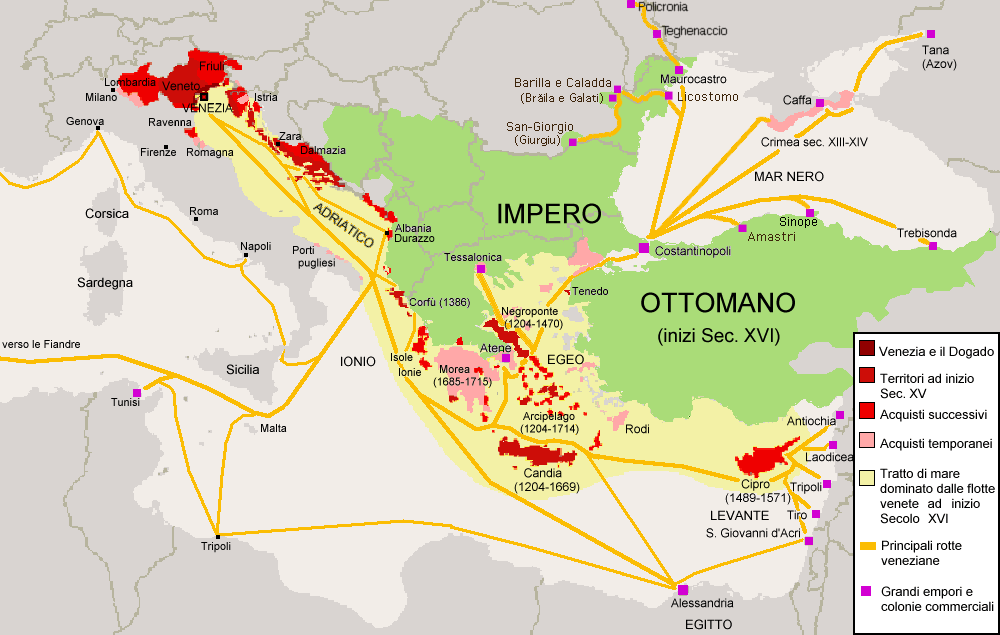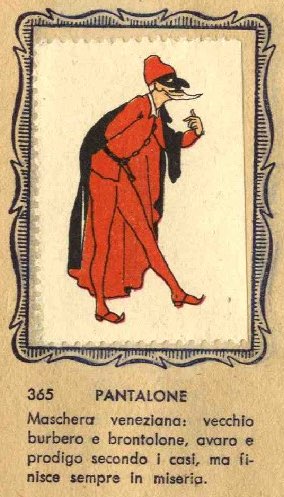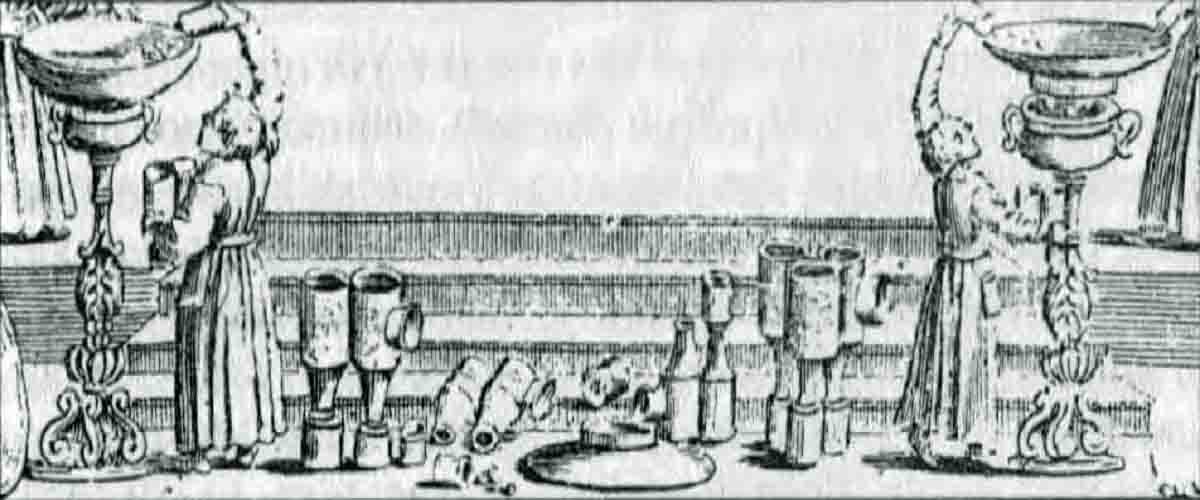Venezia è unica e uno degli aspetti che sempre osservo e che mi affascina è come, già tanti secoli fa, fosse riuscita a far convivere “Credo religiosi” totalmente diversi in uno spazio così piccolo. Venezia già da secoli esempio di tolleranza e di rispetto dell’altro. La vita religiosa ha avuto importanza pari a quella politica ed economica. Partendo dalle origini, passando dalle splendide epoche del ‘500 e del ‘700, fino ad arrivare ai nostri giorni, doge, patriarca e commercianti hanno costituito la base per lo sviluppo della città e della sua laguna, rendendola “unica”.
La ricchezza della supremazia religiosa a Venezia ha lasciato tracce dovunque e non soltanto grazie alla civiltà cattolica, che conta 137 chiese, ma anche a quella ebraica, greca e armena, che hanno contribuito in maniera determinante alla crescita culturale ed artistica della città.
Il ghetto di Venezia, è importantissimo riferimento per gli ebrei e storicamente fu il primo. il Museo Ebraico è ricco di importanti manifatture orafe e tessili databili tra il XVI e XIX secolo, e le Sinagoghe, gioielli risalenti al 1500 difficilmente riconoscibili dall’esterno. Per comprendere pienamente l’anima del quartiere è possibile dormire alla Locanda del Ghetto, mangiare al Kosher Club Le Balthazar, gustare o comprare specialità ebraiche alla caffetteria del Museo, al panificio Volpe o a quello dei Fratelli Albonico.
Nell’Isola di San Lazzaro, poco lontano dal bacino di San Marco, vivono i padri mekhitaristi armeni, dal XVI secolo, qui ci sono i tesori di uno dei primi centri della loro cultura: il monastero, i giardini, la biblioteca ricca di preziosi manoscritti, la pinacoteca e il museo.
A Venezia è presente anche una numerosa comunità di greci-ortodossi vive e si muove intorno alla Chiesa di San Giorgio, che costituisce da secoli il centro religioso e nazionale dell’ellenismo della città lagunare. La sua costruzione risale al 1564 e vanta nomi di architetti famosi, quali Sante Lombardo, Giannantonio Chiona e Bernard Ongarin, al quale si deve la costruzione del campanile inclinato. Eccezionali sotto il profilo artistico sono anche i mosaici all’interno della chiesa, opere di rinomati artisti post-bizantini. Il quartiere dei greci è arricchito dal palazzo del Collegio Flangini, dal 1951 sede dell’Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, che per secoli ha inviato i suoi chierici ed insegnanti in numerose regioni dell’oriente.
La comunità Valdese di Venezia si costituisce nel Natale 1867 e un anno dopo si inaugura la sede del settecentesco Palazzo Cavagnis, che oggi accoglie anche un attivo centro culturale e una foresteria. Intense e frequenti le occasioni di collaborazione con la Chiesa Luterana, ma nel corso del tempo è con la Chiesa Metodista che si condividono attività, programmi e cura pastorale, fino a quando nel 1977 le due comunità stipulano una convenzione che permette di mantenere le proprie specificità pur essendo inseriti in un’unica organizzazione locale.
Alla comunità evangelica sono dedicate due chiese. In Campo Santi Apostoli si trova la Chiesa Evangelica Luterana, che oggi ospita lezioni di canto gospel, la cui comunità è la prima presente in Italia, già ai tempi della Riforma. Oggi si contano circa 7000 membri, in buona parte di origine tedesca.
Ricavata nel corpo di un antico palazzo patrizio, ristrutturato e riadattato per l’uso, la chiesa anglicana Saint George’s si trova in campo San Vio ed è frequentata da una comunità piccola ma molto attiva. E’ utilizzata spesso per matrimoni di coppie soprattutto inglesi, che possono fare riferimento anche al vicino consolato, ai piedi del Ponte dell’Accademia. All’esterno della chiesa, a ridosso delle porte bronzee, vi sono alcune statue che commemorano i soldati inglesi caduti a Venezia durante la seconda guerra mondiale.
Un crocevia di popoli e fedi che hanno contribuito ad arricchire il patrimonio artistico e culturale di Venezia facendone una città unica al mondo.
Alberta Bellussi
- 17 January 2023
- No Comments