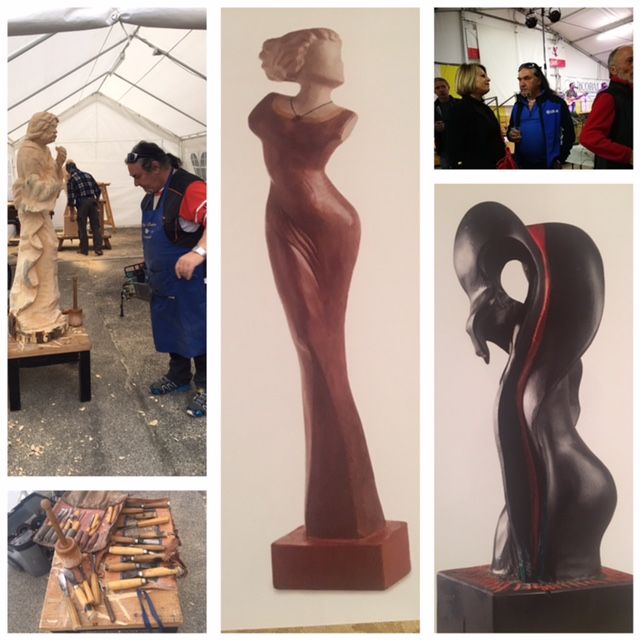Non so se capita anche a voi ma quando scendo con il traghetto al Lido di Venezia in quel meraviglioso viale pieno di rigogliosi alberi costeggiato di Ville fiorite e sfarzose, vedo la raffinata spiaggia con le capanne, i lussuosi alberghi, mi sembra di essere catapultata nell’elegante atmosfera di inizio del secolo scorso con le signore in abiti sciccosi e ombrellino di pizzo.
Eppure sembra strano ma questa lingua di terra che s’allunga tra l’Adriatico e la laguna, fino a metà Ottocento, era un insieme di dune rosse, qualche campo coltivato e casette di pescatori. Sfoggiava una natura così selvaggia e profumata che i primi viaggiatori del Gran Tour l’annotarono sui loro taccuini, affascinati da una flora sgargiante su una terra sabbiosa e salmastra.
Tra l’ottocento e il novecento, in piena Belle époque, sorsero i primi stabilimenti balneari, alberghi e sale da gioco che attrassero il meglio della borghesia europea, da cui deriva quell’aria di sontuosa eleganza che rese famoso il Lido sin d’allora.
Infatti tra fine ottocento e inizio novecento il Lido di Venezia fu la meta della nobiltà mitteleuropea, manifestatasi con la straordinaria espressione artistica del Liberty delle loro residenze, ville raffinate e fiorite e dei grandi alberghi di lusso. Ora il Lido di Venezia è famoso perché accoglie le celebrità che giungono per la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.
Le atmosfere descritte da Thomas Mann con La Morte e Venezia, ispirate ai lussuosi hotel affacciati sul Lungomare del Lido fra pini marittimi e ville in stile liberty, si vivevano nell’Hotel Des Bains, nelle sue sale dagli stucchi dorati e dalle famose terrazze affacciate sul mare. L’hotel è stato meta preferita dai letterati, musicisti e poeti nonché nobili della decadente nobiltà austro ungarica e russa; è attualmente in fase di restauro.
Tanto il Des Bains rappresentava con la sua struttura austera e imponente un mondo classico da residenza reale, quanto il Grand Hotel Excelsior celebra il trionfo dell’architettura moresca; la residenza fiabesca di mosaici dorati, dove si mescolano sfingi e cupole, merlature e torrette è immersa in un’oasi di verde fra palme e siepi di ibisco. Centro della cultura internazionale e della mondanità del cinema, ha accolto personalità e reali di tutto il mondo nei suoi splendidi saloni, talvolta usati come set cinematografici. Nel 1932 l’Excelsior fu scelto come sede della prima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica dando il via ad una tradizione che si protrae sino ad oggi. Anche se attualmente la passerella delle celebrities si svolge nel vicino Palazzo del Cinema, il cuore della mostra rimane la terrazza panoramica dell’Excelsior dove sono ospitati i più famosi VIP e dove quella meravigliosa atmosfera decadente di un passato raffinato e lussuoso si respira ovunque.
Un vero capolavoro di eleganza e sinuosa leggerezza e sensualità è la facciata di un altro storico hotel del Lido: Ausonia Hungaria. Una visione di grande impatto emotivo, un capolavoro del liberty, un intreccio prezioso di elementi decorativi fra ghirlande floreali e eteree figure femminili; insomma: il trionfo della bellezza. L’hotel aprì nel 1907 col nome “Hungaria” in onore degli ospiti ungheresi assidui frequentatori. “Ausonia”, antico nome dell’Italia, fu aggiunto negli anni ’20 come tributo all’identità nazionale. L’hotel da subito si distinse per il suo fulgore fra gli edifici liberty del Lido; il rivestimento della facciata principale in piastrelle di maiolica, opera del ceramista bassanese Luigi Fabris, è un complesso equilibrio simbolico composto da motivi vegetali verdi e ocra, frutti e ghirlande di fiori, puti e allegorie femminili di Venezia e Ungheria.
Il Lido merita davvero di essere visitato.
Alberta Bellussi
- 14 August 2020
- No Comments