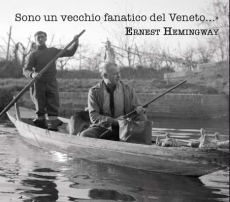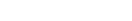…. Prosecco… sono giorni che è su tutti i giornali più famoso di una star ora zona Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco : prime pagine, reportage, servizi…il 2020 sarà di nuovo un’annata anomala…tutto il mondo agricolo dipende dal tempo, dal sole e dalla pioggia.
Bolla di sapone o solido diamante? …. amatissimo o criticato ?
Vero è che da sempre quando una cosa funziona si cerca un po’, in tutti i modi di attaccarla, per un costume tutto italiano ma è innegabile che questo vino bianco brioso ha dimostrato di avere in sé potenzialità tali da contribuire con i suoi numeri a battere nelle vendite i consolidati cugini d’oltralpe.
Non si arresta la crescita dello spumante italiano, che chiude il 2019 con l’ennesimo dato positivo della domanda estera, che, per la prima volta, ha superato i 4 milioni di ettolitri (+8%), a fronte di un +5% dei corrispettivi introiti. Bene anche i consumi interni, +6% complessivamente e produzione che cresce proporzionalmente per arrivare a superare i 760 milioni di bottiglie, di cui i i due terzi prendono la via dell’estero, per un valore stimato di 3,3 miliardi di euro, come raccontano i dati elaborati da Ismea.
Analizzando proprio l’export, pur in un contesto positivo per il 2019, c’è da registrare un sostanziale rallentamento della corsa degli spumanti italiani, che, per anni, avevano registrato incrementi a due cifre. Altro aspetto da sottolineare è che, pur essendo cresciuto tutto il settore spumantistico, la domanda estera è trainata essenzialmente dal Prosecco: una dipendenza eccessiva da un unico prodotto che in molti percepiscono come una debolezza del sistema. In effetti, il Prosecco, il 65% dell’intero export a volume di spumanti, è cresciuto del 21% a fronte del -10% dell’Asti, accompagnato da un ridimensionamento significativo anche degli altri spumanti Dop.
Non vi voglio parlare dell’aspetto economico bensì della sua origine storica per cercare di fare un po’ di ordine in mezzo a un mare di informazioni.
Il Prosecco è un vino di origine antica ma un vino per essere “grande” deve essere intimamente legato al territorio di produzione valorizzandone la storia, la cultura, la tradizione.
Il vitigno del Prosecco ha origine, in territorio triestino, e ha preso il nome dal Comune di Prosecco; frazione del Comune di Trieste, sull’altopiano carsico (quasi in Slovenia), che raccoglie nel suo territorio gli splendidi vitigni da cui si ricava l’omonimo vino. Tra questi, quello delle uve Glera, dai lunghi grappoli e dagli acini dorati, che costituiscono in genere l’85% delle bacche utilizzate nella produzione del Prosecco; una piccola frazione, comunque non superiore al 15% del totale, può essere costituita da verdiso, bianchetta trevigiana, perera, glera lunga, chardonnay, pinot bianco, pinot grigio e pinot nero vinificato in bianco.
Verso la fine del 500 l’identificazione del castellum nobile vino Pucinum con il Castello di Prosecco, sito nei pressi dell’omonimo comune portò alla denominazione definitiva del vino in Prosecco.
A questo proposito lo storico Villafranchi, nel 1773, nel suo saggio “Enologia Toscana”, scriveva “… Tra quelli d’italia era dai Romani infinitamente gradito il vino Puccino, latinamente Puxinum, oggi giorno detto Prosecco, che tuttora si raccoglie nel pendio del monte di Contuel in faccia al Mare Adriatico, poche migliaia distante da Trieste…”.
La nascita storica del vino con questo nome, quindi, ci riconduce al Friuli-Venezia Giulia.
Non si conosce quando e in che modo l’antenato del Prosecco sia giunto dal Carso alle terre di Conegliano – Valdobbiadene, ma questa data è stata fissata negli ultimi decenni di vita della Repubblica di Venezia, intorno al 1750. Mentre la Serenissima era ormai al tramonto sorgono nelle colline di Conegliano-Valdobbiadene nuovi fermenti proprio in quel settore che da molto tempo appariva il più trascurato quello enologico. Qui il vitigno trovò il suo habitat naturale; ha dato e continua a dare il meglio di sé.
Infatti, agli inizi del ‘800, Francesco Maria Malvolti, in sede all’Accademia di Conegliano, notava “… chi non sa quanto squisiti siano i nostri Marzemini, Bianchetti, Prosecchi, Moscatelli…”.
In seguito al Congresso di Vienna del 1815 l’imperatore dell’Austria-Ungheria, succeduto al governo del Lombardo Veneto, alla Repubblica di Venezia e poi a Napoleone, spinto dalla necessità di conoscere il patrimonio viticolo della regione da incarico al Conte Pietro di Maniago di formulare un catalogo dei vitigni coltivati, che questo gli consegnerà nel 1823.
Maniago cita per le colline di ConeglianoValdobbiadene la Perella, la Pignoletta bianca, la Verdisa lunga, dell’Occhio, Marzemino nero e Prosecco.
Verso il 1850, quando queste terre appartenevano ancora all’Impero Austro-Ungarico, lo studioso Gian Battista Semenzi a proposito dei vini prodotti nel Conegliano-Valdobbiadene afferma:” Nelle colline le uve producono i squisitissimi vini bianchi sono: la Verdisa, la Prosecca e la Bianchetta. Questi vini venivano venduti in Carinzia e in Germania cioè in quella Mitteleuropa di cui il Veneto faceva parte integrante”.
Alcuni anni dopo la nascita dello stato Italiano(1861) il parlamento decide di redigere un’indagine sulle condizioni dell’agricoltura italiana chiamata “Inchiesta Jacini”.
Per il territorio di Conegliano-Valdobbiadene i ricercatori consigliano di estirpare i vecchi vigneti e sostituirli con altri di qualità superiore. All’epoca si producevano nel comprensorio di Conegliano-Valdobbiadene 25000 hl di Verdiso, 6600 di Bianchetta, 3800 di Boschera e 3200 di Prosecco che quindi era un vitigno del tutto secondario.
Alcuni anni più tardi, nel 1868, grazie all’impegno del Dottor Antonio Carpenè e dell’Abate Felice Benedetti, presidente del Consorzio Agrario di Conegliano, viene fondata sempre a Conegliano la Società Enologica Trevigiana. Questa nuova istituzione fu di portata dirompente per l’ancora stagnante viticoltura Trevigiana innescando una rivoluzione vitivinicola i cui frutti positivi iniziano ben presto a farsi vedere, specie per il Prosecco che verrà allevato sempre più in purezza, mentre prima era misto con altre varietà.
I meriti di aver dato inizio alla storia moderna del Prosecco vanno al Conte Marco Giulio Balbi Valier che negli anni successivi al 1850 aveva isolato e selezionato un clone di Prosecco migliore degli altri, individuato ancora oggi come “Prosecco Balbi”.
Va ricordata la Scuola di Viticoltura ed Enologia di Conegliano nata nel 1876 come erede della Società Enologica Trevigiana. Questa scuola concepita da Antonio Carpenè insieme a Gian Battista Cerletti ha avuto tra i suoi docenti più noti, personaggi di altissimo prestigio internazionale come Arturo Marescalchi, Giovanni Dalmasso e Luigi Manzoni i quali posero le basi per la moderna Scienza viticola ed enologica.
Ma è nell’ultimo dopoguerra che il Conegliano-Valdobbiadene esprime al meglio le sue grandi potenzialità. E’ concluso da poco il Secondo Conflitto Mondiale quando i più attenti viticoltori di Valdobbiadene si organizzano per difendere, valorizzare la viticoltura collinare e l’antica tradizione vitivinicola, costituiscono il 14 agosto 1945 la Confraternita dei Cavalieri del Prosecco.
Nasce così il 7 giugno 1962 il Consorzio di Tutela del vino Conegliano-Valdobbiadene Prosecco con sede a Villa Brandolini presso Solighetto di Pieve di Soligo. Da allora il Consorzio opera con grande intelligenza e determinazione per difendere, valorizzare e promuovere l’immagine del Prosecco facendolo conoscere non solo in Italia ma anche all’estero offrendo agli estimatori di tutto il mondo caratteristiche inimitabili proprie soltanto della terra d’origine ossia ConeglianoValdobbiadene.
Il risultato dell’impegno dei produttori e del Consorzio di Tutela si fanno subito vedere tanto che nel 1963 Valdobbiadene diventa ufficialmente capitale non solo del Prosecco ma dell’intero mondo dello spumante italiano con la Mostra Nazionale degli Spumanti che ogni anno a settembre, organizzata dalla Confraternita dei Cavalieri del Prosecco, ha luogo nella prestigiosa Villa dei Cedri di Valdobbiadene. Punto d’incontro tra tutti gli spumantisti italiani fra cui quelli di Prosecco occupano un posto di tutto rilievo.
Alcuni anni più tardi, nel 1969 il Conegliano-Valdobbiadene conquista un altro prestigioso risultato quando il comprensorio collinare ottiene la DOC e il vitigno Prosecco il maggiore riconosciuto dal disciplinare di produzione. Questo riconoscimento viene osservato sempre con maggiore interesse anche lontano dalla zona di produzione e comincia ad essere richiesto nei ristoranti ed enoteche più esclusive di tutto il mondo. In questi anni il Conegliano-Valdobbiadene Prosecco DOC è divenuto il vino bianco più richiesto in italia e nel mondo
Lo straordinario successo ottenuto dal Prosecco a partire dal secondo dopoguerra ha creato una serie di tentativi di imitazione: vini denominati “Prosecco” sono stati prodotti in Sudamerica (“Prosecco Garibaldi” in Brasile), in Croazia (“Prošek”), in Australia (“Prosecco Vintage”) eccetera.
Diventando quindi urgente una regolamentazione legislativa che arginasse il fenomeno ed essendo vietato dalle norme internazionali proteggere il nome di un vitigno (era invalso infatti l’uso di chiamare “Prosecco” il vitigno produttore del vino), si rese necessario ricollegare la produzione veneta col nome della località originaria del Prosecco, e cioè la località omonima presso Trieste, nel contempo ripristinando gli antichi nomi – “Glera” e “Glera lunga” – dei vitigni.
Si decise quindi di creare un’area di produzione contigua costituita dalle province del Veneto e del Friuli Venezia Giulia ove il vitigno era autorizzato o era stato avviato il procedimento autorizzativo. L’iter venne concluso il 17 luglio 2009, con la promulgazione del decreto di riconoscimento della DOC “Prosecco”, delle due DOCG “Conegliano Valdobbiadene – Prosecco” e “Colli Asolani – Prosecco” (o “Asolo – Prosecco”) e del relativo disciplinare di produzione. La riorganizzazione di tutta la produzione ha avuto luogo a partire dalla vendemmia iniziata il 1º agosto 2009.
Dal 2019 tutta l’area per la sua bellezza e l’originalità delle sue vigne è diventata Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.
E che anche quest’anno le bollicine di Prosecco DOCG e DOC portino momenti di convivialità e allegria tra amici di tutto il mondo.
Alberta Bellussi